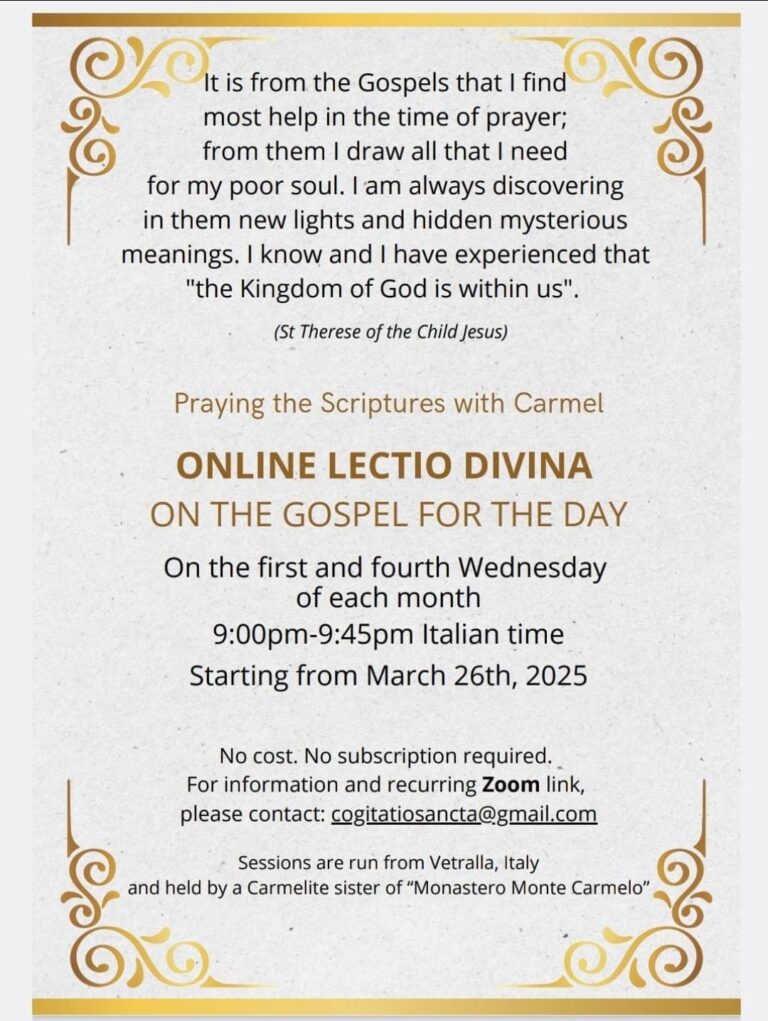III DOMENICA DI PASQUA
Gv 21,1-19
Il capitolo 21 di Gv, da cui è tratto il brano evangelico, si presenta come aggiunto, perché 20,30-31, che precisa di aver operato una scelta nella presentazione dei “segni” compiuti da Gesù e di voler suscitare la fede, suona quale conclusione di tutto il libro, mentre 21,24-25 segna un’ulteriore finale, anche con ripresa dell’altra; l’aggiunta trova corrispondenze con il corpo del vangelo, ma anche elementi distinti (per esempio mai si trova in esso l’espressione che si incontra qui: “i [figli] di Zebedeo”). Comunque si tratta di un testo molto antico, documentato già nella seconda metà del II sec.: dovrebbe significare che esso è stato unito al quarto vangelo ancor prima della sua diffusione. Ci si premura di avere collegamenti con quanto precede; subito, nel v.1, viene affermato “Dopo queste cose”, poi al v.14 viene specificato che è la “… terza volta (che) apparve…”, perché sono contate anche le due apparizioni del cap.20, che, dal punto di vista storico, dovrebbero essere successive.
Si parla comunemente, e con ogni probabilità a ragione, di tradizione galilaica, dato che tutto l’episodio è ambientato in Galilea; così l’aggiunta, rispettando la finale già scritta, supplirebbe alla mancanza del quarto vangelo a dare notizia di apparizioni in quella regione (cf Mt 28,7.16-20; Mc16,7); storicamente, con tutta verosimiglianza, quella qui narrata sarebbe, se non la prima, tra le prime apparizioni del Risorto: infatti i cinque apostoli menzionati per nome, più i due innominati appaiono disillusi e come rassegnati (cf Lc 24,21) e ritornano al mestiere di pescatori, inoltre non c’è traccia del mandato ricevuto in 20,21. Non si può cercare nei vangeli la consequenzialità lineare dei fatti, perché, come si richiama spesso, essi non fanno in via prioritaria cronaca, ma sono interessati a promuovere la fede cristiana e adottano procedimenti che possono essere oggetto solo di congettura. Si deve ritenere sintomatico in relazione al primato di Pietro che sia lui ad avere l’iniziativa di tornare a pescare e sia presentato come capo della piccola comitiva.
Nel brano liturgico si possono distinguere tre scene: la pesca miracolosa, il banchetto sulla riva, il colloquio con Pietro.
Nel momento più favorevole per la pesca, la notte, i pescatori non prendono nulla, mentre in un periodo del giorno quanto mai sfavorevole, “quando già era l’alba”, seguendo il suggerimento di Gesù, fanno una pesca abbondantissima: il vangelo sottolinea così il contrasto fra le due situazioni e mette in risalto maggiormente la grandiosità dell’intervento del Signore. L’appellativo, “figlioli”, con cui egli si rivolge ai pescatori è quello familiare con cui si interpellano amichevolmente persone semplici: potrebbe corrispondere più o meno all’italiano “buona gente”. La domanda, nella sua formulazione, già aspetta risposta negativa, per richiamare la pochezza degli Apostoli, lasciati alle sole loro forze. Se, secondo il racconto, essi si fidano subito dell’indicazione di chi non riconoscono, quindi di uno sconosciuto, significa che si tiene presente il punto di vista, non dei personaggi, ma del narratore che, scrivendo attorno al 100, sapeva bene di chi stava parlando. Per molti aspetti l’analogo racconto della pesca miracolosa in Lc 5,1-11 pone problemi simili: Gesù è presentato come “Maestro” (v.5) in cui si ha piena fiducia per calare le reti, ancora prima di essere seguito.
In Gv il primo a riconoscere il “Signore” è “quel discepolo che Gesù amava”; si ricorda che, con riferimento all’AT, il titolo usato per Gesù richiama la sua divinità.
La nudità di Pietro probabilmente va intesa non come semplice riferimento pittoresco all’abbigliamento approssimativo di un pescatore, quanto con valore teologico profondo ad esprimere ancora ed efficacemente la nullità dell’uomo davanti al Divino (cf Lc 5,8).
L’espressione “centocinquantatré grossi pesci” non comporta che qualcuno si sia preso la briga di controllare la quantità della pesca miracolosa, ma riporta un numero troppo preciso per non avere esso un valore simbolico, solo che non si è in grado di stabilire esattamente quale. Sulla base di un’opinione molto diffusa, sostenuta nell’antichità anche da un autorevole studioso come San Girolamo, secondo zoologi antichi proprio quello era il numero delle specie dei pesci presenti nei mari, quindi il particolare esprimerebbe totalità e integrità. Altri fanno notare che si tratta di un numero “triangolare” che si ottiene dalla somma di tutti i numeri, da 1 a 17, il numero primo indivisibile; si indicherebbe completezza. Si ricorda ancora un’altra opinione che si rifa ad un procedimento molto diffuso tra i Giudei, la “ghematria” che vede nascosta sotto i numeri una proposizione (l’esempio biblico più noto forse è “il numero della bestia” di Ap 13,18); considerando le consonanti ebraiche corrispondenti ai singoli valori numerici, dalla somma si ottiene l’espressione ebraica dal significato di “l’assemblea (chiesa) dell’amore”. Sembrerebbe allora probabile che da quel numero si possa ricavare l’idea di interezza e completezza.
Pietro trae la pesante rete e “benché fossero tanti, la rete non si squarciò”. Un uomo da solo, se non dotato di forza sovrumana, non può spostare una tale quantità di “grossi pesci”; anche in questo particolare si deve vedere un riferimento teologico alla funzione di Pietro come capo della Chiesa, e all’integrità infrangibile della comunità cristiana (cf pure Gv 19,23-24). Dalle acque malferme e spesso agitate si va sulla terraferma da Gesù: è la stabilità assoluta che lui procura nella vita eterna.
Sulla riva Gesù ha già preparato pane e pesce arrostito, si prende cura dei suoi e non avrebbe bisogno di nessuno, però chiede altro pesce dalla pesca appena fatta, probabilmente per indicare la necessità della collaborazione umana.
La triplice domanda sull’amore di Pietro dovrebbe riferirsi al suo triplice rinnegamento (cf 18,17.25-27), come lascia intendere anche il fatto che, secondo la presentazione narrativa, lui ne resta addolorato (la diversità dei verbi probabilmente ha la semplice funzione letteraria di variare), ma qui si tratta di un fatto non solo personale, come nel caso del rinnegamento, bensì anche ecclesiale. Il mandato ripetuto tre volte conferisce maggior solennità a tutta la scena e, soprattutto, indica missione ufficiale con valore giuridico, perché a volte dal diritto ebraico era richiesto un triplice pronunciamento davanti a testimoni (cf anche Gn 23,3-18). Gesù risorto affida a Pietro la guida della Chiesa con la metafora di pascere il gregge (cf 10,4.27) (la distinzione fra “pecore” e “agnelli” forse deriva solo dal fatto estetico della volontà di evitare una ripetizione, quindi non pare debba essere sottolineata). Il particolare “più di costoro” fa capire che il primato di Pietro è fondato anche su uno speciale legame d’amore con il Signore (qui si può vere operante il comando di confermare i “fratelli” in seguito al ravvedimento – cf Lc 22,31-32); del resto il vangelo è scritto abbondantemente dopo il martirio di Pietro, annunciato con l’immagine del vecchio che barcolla e viene condotto anche dove non vuole (si indica una morte violenta senza specificarne le modalità); in tal modo egli aveva dimostrato la sua fede in Cristo e rispettato pienamente il “seguimi”, tipico di ogni vero discepolo.