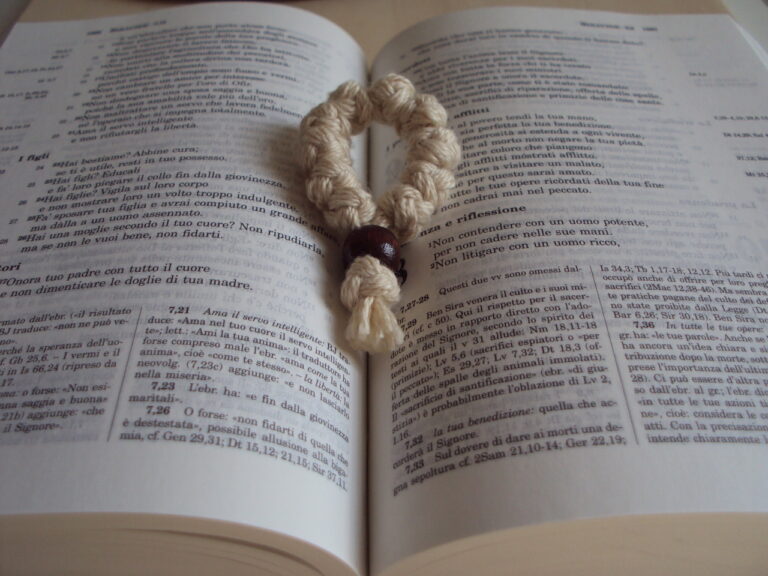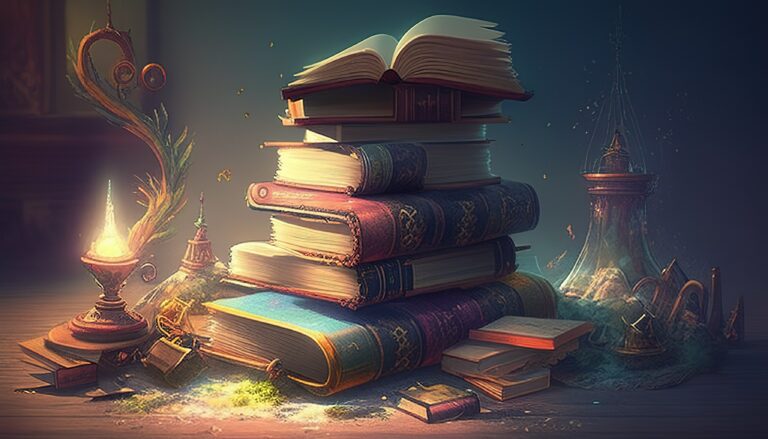Presentazione del Vangelo della Domenica
XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Lc 10, 25-37
Il passo presenta una formidabile lezione sulla necessità di soccorrere chiunque si trovi nel bisogno e fa capire che spesso uno qualificato negativamente può essere migliore; è possibile ricordare le ripetute raccomandazioni profetiche di come il Signore desideri la misericordia piuttosto che i sacrifici o l’affermazione molto aperta di Pietro nel racconto degli Atti degli Apostoli, quando entra in casa del centurione Cornelio: “Con verità mi convinco che non è parziale Dio, ma in ogni nazione temente lui e operante giustizia accetto a lui è” (At 10,34-35)
Il racconto vero e proprio del “buon Samaritano” si trova solo nel vangelo secondo Luca; invece il dialogo sull’amore e la Legge che lo precede immediatamente, si ha anche negli altri Sinottici, sia pure in contesto diverso. Il brano appare inventato, ma non sembra del tutto esatto qualificarlo come parabola, in quanto questa presenta una sorta di similitudine da decodificare per estrarne l’insegnamento, mentre qui il messaggio è subito evidente con la presentazione di un esempio da imitare, come risulta chiaro nella conclusione: “… fa’ similmente”; allora si ritiene meglio parlare di “racconto edificante/didattico/esemplare”, o simile.
L’atteggiamento del “dottore della Legge” è malevolo: “sorse, mettendolo alla prova”; può darsi che la cosa dipenda dalla data di composizione; infatti storicamente sembra più probabile la versione dell’episodio analogo (si è nella sorta di proemio, come si notava, comune a tutti i Sinottici) da parte di Mc (cf 12,28) in cui il richiedente, definito “uno degli scribi”, è benevolo; Lc, datato comunemente nel corso degli anni 80, rispecchierebbe un’epoca in cui era sorta ostilità tra Cristiani e Giudei (si ritiene intorno al 70); Mc dev’essere precedente, quando il cristianesimo era considerato un movimento all’interno del giudaismo (prima di rendersi conto che esso rappresentava una via alternativa ed esclusiva). Dal contesto risulta che la prova consiste nel presentare il ruolo per la salvezza da parte della legge di Dio predicata dai missionari cristiani (sembra si supponga che il personaggio abbia assistito al discorso della missione dei vv.1-24). Comunque anche qui, con l’appellativo “Maestro”, si riconosce in Gesù l’autorevolezza di indicare la via di Dio. In gioco è la vita eterna: “cosa facendo, potrò ereditare la vita eterna?”, la vita stabile, definitiva. L’interlocutore è presentato coinvolto personalmente: parla in prima persona, è una questione che proprio gli sta a cuore e lo riguarda direttamente, perché era un problema molto sentito dai discepoli dei rabbini (cf anche 18,18); la malizia iniziale, nel corso del discorso, pare dimenticata a favore di un vero interessamento.
Gesù conferma la validità della Legge per garantire la salvezza e la Vita; il termine “legge” traduce, attraverso il greco “nómos”, la “tôrāh” del canone ebraico, corrispondente al Pentateuco cattolico: il sostantivo ebraico appartiene alla radice “yrh” che significa indicare la via da seguire (anche in senso figurato-etico) e designa l’istruzione come direttiva di vita; si può continuare a parlare di “Legge”, ma da intendersi in senso lato. E le indicazioni sono riassunte, con la risposta dell’esperto alla domanda del Signore, nell’amore di Dio e del prossimo: la prima norma (cf Dt 6,5) esprime l’adesione a Dio con tutte le proprie forze spirituali. Come nel passo parallelo di Mt (cf 22,37), si parla solo dell’amore che l’uomo deve portare a Dio; in realtà questo è solo risposta all’iniziativa divina: lo fa capire molto bene Mc, citando anche il v.4 di Dt 6, dove il Signore è qualificato “Dio nostro” (cf Mc 12,29-30; Dt 6,4-5 e pure Es 20,2). Legato a questo primo comandamento, si presenta anche quello dell’amore verso il prossimo (cf Lv 19,18). Il discorso, poi, si concentra su questo, però va notata una differenza fondamentale: il legista aveva chiesto: “E chi è mio prossimo?”; l’interrogazione finale cambia radicalmente prospettiva: “Chi … ti sembra sia stato prossimo…?”; invece di qualificare come prossimo chi è stato oggetto di misericordia, viene chiamato così l’autore di essa. Uno non può cercare di limitare il campo della sua “misericordia”, mettendosi al centro, e compilando quasi una lista di quelli da amare, ma soccorre chiunque si trovi nel bisogno, come già notato, senza preoccuparsi dell’appartenenza nazionale, religiosa o altro. Va rilevato che il vangelo insiste molto sul “fare”, come per portare a capire che non basta dire, ma bisogna soprattutto agire: “cosa facendo …?” in vista della vita eterna; “fa’ questo e vivrai”; “fa’ similmente”.
Il Narratore dimostra di conoscere bene l’ambiente geografico, quando dice: “Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico…”, perché fra le due città v’è un dislivello di oltre 1000 m. con una distanza di una trentina di chilometri; quindi il percorso è molto scosceso, se si aggiunge che esso attraversa una zona desertica con passaggi obbligati, si può capire come risulti un luogo “ideale” per imboscate e rapine. Allora si deve concludere che il caso previsto nel racconto evangelico è del tutto verosimile.
Il “sacerdote” e il “levita”, pur vedendo, non intervengono; con ogni probabilità, trattandosi di addetti al culto, tornarono da Gerusalemme dopo aver prestato il loro servizio nel tempio (del sacerdote è detto esplicitamente che “scendeva”, del levita viene detto solo “giunto”, ma dal contesto si può dedurre che anche lui andasse nella stessa direzione; comunque non è questo il punto che vuole sottolineare il vangelo, ma piuttosto mettere in evidenza il non-interessamento da parte dei due): non si lasciano minimamente toccare dalla situazione di quell’infelice, tutto presi dalle loro cose; forse vogliono anche evitare il pericolo di contrarre impurità per il contatto con un moribondo o un morto (così doveva apparire ai loro occhi il ferito) (cf Lv 21,1-4; Nm 19,11); in ogni caso, fermandosi all’esteriorità, a norme ritualistiche o simili, trascurano il nucleo fondamentale della Legge, l’amore, com’è stato richiamato subito prima del racconto (cf Os 6,6). Ben diverso rispetto ai rappresentanti ufficiali del giudaismo è il comportamento del Samaritano, appartenente ad una categoria di persone dai Giudei considerate eretiche e scismatiche, da evitare (cf 9,52-53; 17,16.18); si trova in presenza di un uomo, sconosciuto, ma in grave difficoltà, che ha bisogno d’aiuto e se ne fa carico, dandogli la precedenza rispetto ai propri affari e per lui spende tempo e denaro. Significativo è il verbo usato: “esplagkhnísthē”, una forma di “splagḳízomai” che evoca un’emozione profonda ed esprime l’amore “viscerale”, fisico, tipico della mamma verso i figli. Quel verbo nel NT si trova solo nei vangeli sinottici e sempre per esprimere la compassione di Gesù (l’unica eccezione sarebbe il caso presente: anche per questo si è autorizzati a ritenere che pure qui sia indicato lui) o di Dio (pure indirettamente, sotto la figura del padre misericordioso che accoglie il figlio prodigo – cf Lc 15,20, o del signore/padrone compassionevole che condona al servo il debito ingente – cf Mt 18,27), ma, dato che l’amore di Dio si incarna in Gesù, tutti i testi riportano a lui. Allora, sotto le sembianze del “Buon Samaritano”, dietro il suggerimento di molti Padri della chiesa, si può vedere lui stesso, che si china sull’umanità in vari modi ferita e sofferente: è il suo amore, nucleo fondamentale della via cristiana, a muovere il mondo (cf II Cor 5,14). Si possono vedere analogie con il discorso del “buon pastore” di Gv 10,1-18. Il vangelo termina invitando ad imitare l’esempio dato a farsi prossimo di chi si trova nel bisogno, com’è stato più volte ribadito, in quanto si tratta del messaggio di fondo del testo.