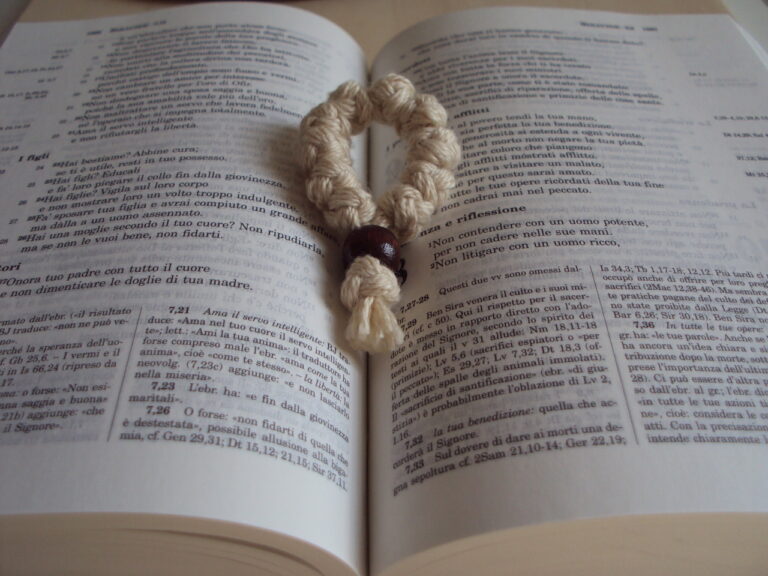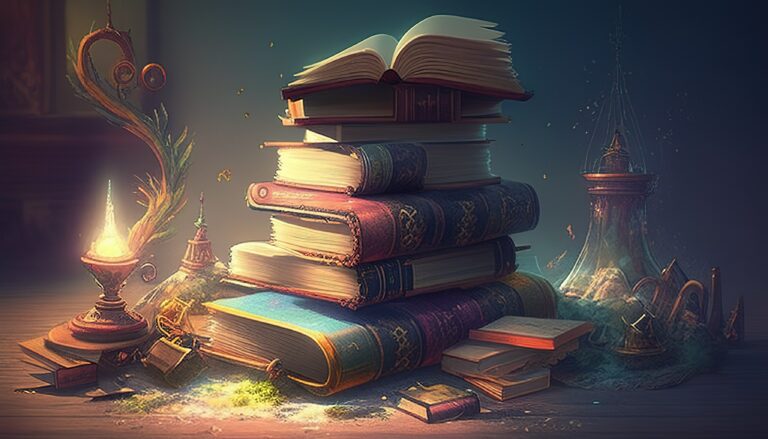Presentazione del Vangelo della Domenica
XIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Lc 10,1-12.17-20
Il brano, che nel vangelo di Luca rappresenta la riflessione più sviluppata sul mandato missionario, riporta le prime battute della sezione del grande viaggio di Gesù verso Gerusalemme, detto “grande inserto lucano” (9,51-19,27/28), dove nella sua narrazione kerigmatica l’autore del terzo vangelo adatta la salita alla città-santa presentata da Mc 8,26-10,52; con quest’opera fondamentalmente quello coincide, sia nel contenuto che nella sequenza degli episodi narrati (di solito il fatto viene interpretato come segno della dipendenza di Lc da Mc); se ne discosta nella parte presente, dove vengono ambientati passi propri e brani che negli altri Vangeli sono situati in contesti differenti (in tal modo si ha un’ulteriore indicazione che le narrazioni bibliche non perseguono intendimenti cronachistici, ma offrono una sistemazione redazionale per trasmettere l’annuncio). L’orientamento a Gerusalemme viene richiamato più volte (due volte ricordando esplicitamente la meta – cf 13,22; 17,11; altre volte riferendosi genericamente all’azione del camminare, quando la direzione è già stata chiaramente indicata – cf 9,57; 10,1.38; …); l’ultima ricorrenza si ha in 19,28, dove il percorso è concluso e subito dopo inizia la descrizione degli avvenimenti nella città santa o dei preparativi per essi. Ovviamente Gerusalemme non va intesa come semplice luogo fisico, bensì come “luogo teologico” del compimento del mistero pasquale di morte-risurrezione-glorificazione: nel terzo vangelo essa è il punto di partenza, con l’annuncio della nascita di Giovanni Battista e il punto di arrivo, con l’Ascensione; poi in Atti degli Apostoli (dello stesso autore) diventa il centro di irradiazione del movimento cristiano.
Comunemente il passo odierno è qualificato come “missione dei discepoli”, per distinguerla da quella analoga riferita ai “dodici” (cf 9,1-6), ma mai nel testo ricorre il termine “discepoli”; certo l’aggettivo “altri” di “altri settantadue” implica diversità e distinzione, però con l’uso del verbo “apostéllō/invio”, che costituisce la radice del termine “apostolo/inviato”, si dice che pure questi svolgono funzione apostolica; così come si trova, il brano è proprio di Lc, ma con reminiscenze anche di ambientazione diversa, per esempio, Mt 9,37-38; secondo alcuni studiosi si sarebbe in presenza di un “doppione” dell’unica missione precedente: senza affrontare il problema, ci si attiene al testo attuale. Comunque, qui si deve notare che l’orizzonte è più vasto e abbraccia tutto il mondo; infatti si opta per il numero “settantadue”, pure se alcuni manoscritti antichi hanno “settanta” e, sulla base dei principi della critica testuale, non è possibile giungere ad una decisione cogente, perché forse è da preferire, in quanto settanta più facilmente si può spiegare come derivazione da esso per influsso del ricorrere frequente (cf Nm 11,16.17.24.25: i settanta membri del sinedrio) ed è un multiplo di dodici, che esprime totalità (il dodici è legato ai dodici mesi dell’anno e l’uso del calendario lunare con tal numero di mesi è documentato dalla più remota antichità, ben prima della letteratura biblica); settantadue, secondo una concezione ebraica, era il numero delle nazioni in cui erano divisi tutti i popoli della terra (cf anche la tavola delle nazioni di Gn 10,2-31 secondo la versione greca della Settanta, mentre nella versione massoretica si ha settanta). Allora si avrebbe la prospettiva universalistica, specifica del terzo vangelo che troverà espressione completa nel libro degli Atti degli Apostoli (cf At 1,8). Va rilevato ancora che, mentre l’invio dei Dodici è accompagnato solo da qualche breve istruzione (cf Lc 9,3-5), ora, come rilevato, si ha un lungo discorso che in Lc rappresenta l’autentico “discorso di missione”.
Il brano è ben delimitato: il “Dopo queste cose poi” di 10,1 richiama “In quell’ora…” di 10,21, così che risulta come unità letteraria 10,1-20 che è il testo liturgico, tralasciando i vv.13-16 con le severe minacce contro le città del lago, richiamate dalla condanna di chi non accoglie i missionari. Si hanno due parti nettamente distinte: l’invio in missione con le relative consegne (vv.1-12), ritorno dei missionari (vv.17-20).
L’espressione iniziale, del tutto generica, si può intendere semplicemente come transizione letteraria ad un nuovo brano, senza particolari connotati cronologici.
Gesù è chiamato “Signore”: “… il Signore designò …”; sulla penna del Narratore il termine può essere inteso nel senso pieno in dipendenza dalla traduzione greca del nome divino nell’AT per esprimere la fede cristiana nella divinità di Gesù.
“… a due a due…” : per un duplice motivo fondamentale, sostenersi a vicenda e garantire la veridicità della testimonianza (cf Dt 19, 15).
“… dove stava per recarsi…”: il grande missionario è lui; compito degli uomini, da lui voluti come strumenti, è di prepararne l’accoglienza.
L’immagine della “messe” si trova spesso nella letteratura escatologica, riferita agli ultimi tempi, per designare il giudizio finale (cf Gl 4,13); qui dovrebbe indicare tutto il complesso dell’attività apostolica, che porta le persone a decisioni vitali riguardanti anche la fine. Si può notare la sproporzione enorme tra l’abbondanza della messe e l’esiguità del numero degli operai, però il ricorso alla preghiera indirizzata a Dio, “signore della messe”, può eliminare la distanza e garantire l’efficacia dell’opera.
L’invio in missione, espresso con l’imperativo assoluto “Andate”, fa capire che bisogna non aspettare che si muovano gli altri, ma andare loro incontro. La forte metafora degli “agnelli in mezzo a lupi” richiama la mancanza di difese umane da parte dei missionari verso le persone ostili e le difficoltà che essi dovranno incontrare. Ma il vangelo chiede di fare affidamento unicamente su Dio, come subito dopo, quando comanda la più assoluta povertà che poi significa piena libertà e disponibilità: “non portate borsa, …”, senza contare su risorse proprie; la proibizione paradossale di non attardarsi nei saluti, solo in Lc (cf II Re 4,29), anche alla luce della elaborata cerimoniosità delle modalità orientali, esprime la grande urgenza di annunciare il Regno.
Gli inviati devono portare la pace, che potrebbe già essere implicitamente intesa con il riferimento agli agnelli (cf Is 11,6-8); essa dovrebbe essere compresa nel senso biblico di completezza, pienezza di vita. Quale ricompensa della sua attività spirituale è giusto che l’operaio del vangelo usufruisca dell’ospitalità che gli viene offerta, ma, accanto all’accoglienza è previsto, anche il rifiuto, però quest’ultimo caso è accompagnato da un duro avvertimento sulle responsabilità personali: lo scuotere la polvere è un gesto profetico che esprime ripulsa e totale mancanza di comunione (lo compivano gli Ebrei quando rientravano nella terra santa da un paese pagano).
Il racconto del ritorno evidenzia la gioia degli inviati per aver constatato di avere nel nome di Gesù potere sui demoni; il Maestro garantisce la totale e definitiva sconfitta di Satana e dichiara di aver reso i missionari immuni da ogni tipo di danno; però il vangelo invita a gioire piuttosto per l’appartenenza al Regno.giudaici)..