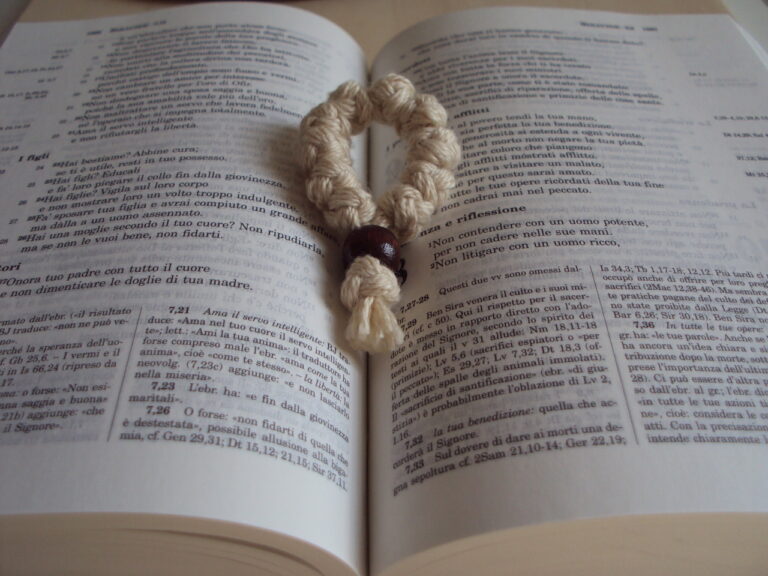Presentazione del Vangelo della Domenica
V DOMENICA DI PASQUA
Gv 13,31-33a.34-35
Il brano dovrebbe costituire l’inizio del primo cosiddetto “discorso di addio” (13,31-14,31: è una possibile divisione tra quelle proposte, per esempio a parere di alcuni il discorso comincia solo in 14,1): si opta per questa soluzione, perché il v.31 del cap.13 rappresenta una nuova tappa del racconto evangelico, segnalata anche letterariamente dall’introduzione “Quando dunque” che ha proprio tale funzione di frequente in Gv; si è appena rimarcato fondamentalmente il senso della lavanda dei piedi, con l’invito ad imitarne l’atteggiamento di umile servizio e si è narrato l’allontanamento di Giuda, ormai in balia di Satana e del potere delle tenebre, quando Gesù comincia a parlare esordendo con “adesso,ora/nu͂n” (in posizione enfatica al principio del discorso); secondo la presentazione del quarto vangelo, il tutto è ambientato nell’intimità del cenacolo dove ha avuto luogo l’ultima cena (non se n’è ancora usciti; lui comanda di partire in 14,31, ma l’uscita effettiva si avrà solo in 18,1). Il Signore fa alcune precisazioni sulla sua attività, dà direttive e promette lo Spirito per far assimilare la Rivelazione e introdurre alla verità intera (cf 14,26; 16,13; …); questo può richiamare per molti aspetti il genere dei “discorsi di addio”, e rappresenta il culmine dell’opera rivelatrice poiché si è nell’ora di Gesù (cf 13,1). Di quei discorsi c’è ricca documentazione in testi giudaici e nella Bibbia: congedo e raccomandazioni ai figli sul letto di morte da parte di grandi personalità del popolo ebraico (cf Giacobbe in Gn 47,29-49,33; Mosè in Dt; Paolo in At 20,17-38; …). Non ostante l’ordine di partenza in 14,31, come già si è notato, segue un altro discorso in 15,1-16,33, poi la preghiera “sacerdotale” in 17,1-26.
Il passo liturgico, come tutti i discorsi, appare composito, quindi è legittimo leggerlo secondo i singoli elementi.
Subito si incontra quello che spesso è ritenuto parte di un inno a Cristo, frammento liturgico derivante dalla primitiva comunità cristiana, come può far pensare l’uso della terza persona; si trovano due forme dello stesso verbo “glorificare”: prima tre volte (due sicure, la terza probabile perché, anche se non attestata da tutti i manoscritti, è accettata da eminenti critici) il passivo al passato (“… è stato glorificato…”), poi due volte il futuro attivo “… lo glorificherà…”), sempre con agente Dio-Padre; quindi vuol dire proprio che il vangelo intende sottolineare il concetto di partecipazione alla gloria. Le prime ricorrenze possono riferirsi alla glorificazione reciproca fra il Figlio incarnato e il Padre nel senso della gloria ricevuta da Gesù nel corso della vita terrena fino al compimento della croce (è notorio che in Gv l’innalzamento sulla croce, oltre all’aspetto materiale-fisico, prevede il valore spirituale di elevazione nella gloria) e che lui a sua volta rese con la sua ubbidienza totale a chi l’aveva mandato (nel suo ministero si rivela la gloria di Dio come potenza salvifica), le altre due alla gloria che riceverà in modo permanente con la risurrezione e ascensione al cielo (a questa lettura potrebbe alludere anche il tempo passato dei primi esempi del verbo, ovvio dal punto di vista dell’autore, non della narrazione), o al ritorno alla fine dei tempi (il “subito”, allora, andrebbe inteso alla luce della relatività del tempo di fronte a Dio – cf Sl 90[89],4; II Pt 3,8), o anche all’attività del Signore risorto, pure se attraverso intermediari. Dato che nessuna alternativa si impone in modo definitivo, sembra meglio restare nell’incertezza, riconoscendo realisticamente la propria limitatezza.
Il vangelo di Giovanni solitamente non si ferma a riportare semplicemente i fatti o le parole di Gesù, ma ne considera e ne presenta la valenza dopo la Pasqua, alla luce della fede della Chiesa (cf, per esempio, 4,23; 5,24-25; 9,22.34-35; 17,2.4.12); per questo motivo la particella “Ora…” iniziale del discorso, per riprendere e completare un’affermazione precedente, con ogni probabilità non è da riferire semplicemente all’uscita di Giuda dal cenacolo, ma anche al presente della chiesa, al cui interno vive l’autore. In ogni caso, viene indicato un nuovo momento nella vita di Gesù. Come sempre, egli è presentato pienamente consapevole: domina la scena e decide delle vicende che riguardano la propria vita. Così la formula “Figlio dell’uomo”, particolarmente nel quarto vangelo, si deve intendere come espressione della fede: traduce l’ebraico “ben ’āḏām” e indica l’appartenenza al genere umano; Gv presenta uno sviluppo rispetto alla tradizione sinottica e usa l’espressione in riferimento al Gesù terreno, ma come oggetto di fede (cf 9,35); insiste molto sul legame col mondo celeste (cf 1,51), da contemplare sempre con la fede. Fondamentale rimane l’unione tra la preesistenza e l’incarnazione e poi il ritorno al mondo divino, il tutto concentrato nel Gesù terreno, considerato con gli occhi della fede.
“Figlioli”: è l’unica volta nel quarto vangelo che Gesù usa quest’epiteto per rivolgersi ai suoi discepoli (invece il termine è frequente nella I Gv, probabilmente dello stesso autore, o, comunque, del medesimo ambito); può darsi che il termine sia introdotto qui per influsso dei discorsi di addio, in cui i patriarchi si rivolgono così ai propri discendenti. In tal modo, in ogni caso, si richiama tutta la vicinanza affettiva del Signore verso i suoi discepoli: i verbi passano alla seconda persona per esprimere raccomandazioni ed esortazioni, e ricordare molto da vicino i già richiamati discorsi.
Adesso si indica la morte-risurrezione del Signore (“ancora per poco sono con voi”), che inevitabilmente comporta separazione dai discepoli, come per i Giudei (cf 8,21), ma, nel caso di questi ultimi il distacco è definitivo, mentre per quelli lui garantisce che è solo temporaneo (cf 14,2-3).
Il “comandamento” dell’amore, che si trova già nell’AT (cf Lv 19,18), è chiamato “nuovo” e può essere considerato tale sotto un duplice aspetto: perché inserito nella “nuova alleanza” (Lc 22,20), e, soprattutto, per il “come” (alla lettera: “come ho amato voi affinché anche voi…”); l’amore fraterno è chiaramente presentato come fondato su quello di Dio manifestato in Gesù (cf 15,9). Il “come” va inteso, non semplicemente con riferimento ad un modello da imitare, ma quale causa, nel senso di “siccome, dato che”; l’amore di Cristo è un po’ l’atmosfera in cui vivono i cristiani; nel medesimo tempo esso è anche la misura (cf. 15,13; I Gv 3,16) del loro appartenergli: Gesù è “la via, …” (14,6) pure come regola ultima. Questo comandamento si può considerare come il legato supremo che il Maestro lascia ai suoi prima di partire.
Viene ribadito del tutto esplicitamente che l’amore reciproco, è il segno distintivo dei suoi seguaci: “Da questo tutti conosceranno che siete miei discepoli …” (cf At 4,32), perché esprime il misterioso principio divino di vita rivelato in Gesù.