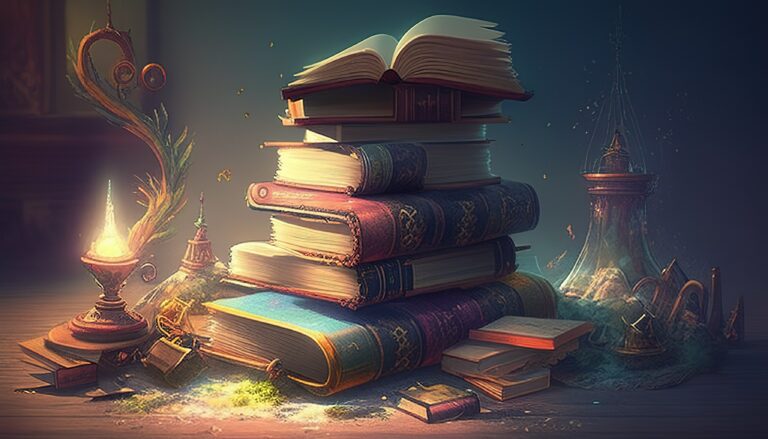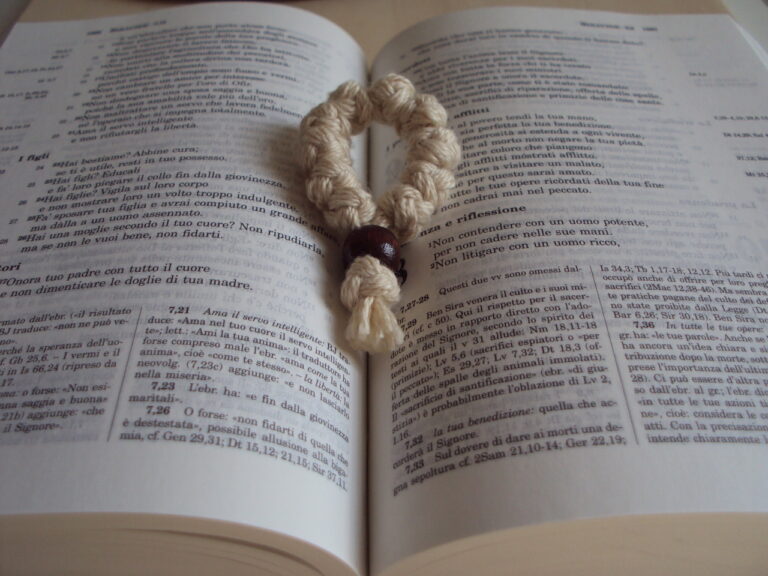Presentazione del Vangelo della Domenica
FESTA DELL’ESALTAZIONE DELLA CROCE 14 settembre 2025
Gv 3,13-17
La festività odierna è tanto importante da avere la prevalenza sulla domenica, di solito intangibile: non ci si ferma alla croce in quanto tale, ma si glorifica chi ad essa è appeso: così la croce per i cristiani è vista come segno della signoria di Cristo su coloro che col Battesimo sono configurati alla sua morte e risurrezione (cf Rm 6,5). La festa, attestata a Roma prima della fine del VII sec., secondo l’opinione comune, prende la data in riferimento all’anniversario dell’inaugurazione della basilica costantiniana del Santo Sepolcro avvenuta il 14 settembre del 335. Costantino (imperatore romano dal 306 al 337) abolì la pena di morte crudele, dolorosa e infamante della crocifissione.
La liturgia offre il passo giovanneo che comincia mediante un dialogo con Nicodemo e si trasforma in monologo, in cui quel personaggio non viene più menzionato e di gran lunga la situazione contingente per contenere ricco materiale teologico, cristologico (cf 3,25-36): secondo la presentazione evangelica, Gesù nella parte dialogica (vv.1-12) parla in prima persona, poi (vv.13-21) passa alla terza persona.
Il brano liturgico inizia affermando che solo Gesù può salire al cielo e ne è disceso: solo lui sa conoscere il mondo celeste, forse contro affermazioni della letteratura giudaica che vedeva persone umane in cielo; sulla base della formulazione più accreditata, nel versetto relativo si può notare la figura retorica di un chiasmo perfetto A) “Nessuno B) è salito C) nel cielo… C’) dal cielo B’) disceso, A’) il Figlio dell’Uomo”. Si tratta della scienza dei misteri celesti irraggiungibili a livello umano (cf Dt 30,12; Pr 30,4), che unicamente Gesù è “disceso” per rivelare: lui è il perfetto Rivelatore (cf 1,51, dove si esprime un’idea simile).
Poi il vangelo cita il racconto piuttosto enigmatico e dal sapore magico di Mosè che, durante l’esodo, innalza su un’asta l’immagine di un serpente di bronzo/rame, perché chi la guardasse con fiducia nella clemenza e potenza di Dio (cf Sp 16,6) non morisse per i morsi dei serpenti velenosi (cf Nm 21,8-9): viene usato come tipo per la crocifissione ed esaltazione di Gesù: in Gv la croce è considerata vertice della glorificazione e culmine della rivelazione. Si ha un bell’esempio della cosiddetta “ironia giovannea”, quando un’espressione, al di là del significato immediato, ne vuole indicare un altro più profondo; qui l’innalzamento si riferisce a quello fisico sulla croce, ma intende pure l’elevazione nella gloria di Dio. Come osservato, già in Nm si possono vedere manifestate confrdenza e speranza nel potere divino, a maggior ragione questo vale per il vangelo, dove si parla formalmente della fede stessa, in vista di ottenere la vita eterna.
Tutto questo viene spiegato (cf “infatti/gár” esplicativo) con l’amore infinito di Dio-Padre per il “mondo”, inteso come l’insieme degli uomini: il dono di Dio comprende certamente l’incarnazione, ma pure l’esaltazione sulla croce. A tale proposito i Padri della Chiesa hanno una squisita osservazione, facendo il parallelo fra Isacco e Gesù: Dio ha fermato la mano di Abramo perché non colpisse il suo figlio (cf Gn 22,12), ma col proprio figlio è andato sino in fondo. Ancora si ribadisce la necessità della fede per la vita eterna, la partecipazione alla signoria divina, che in Gv, a differenza dei Sinottici, inizia già sulla terra: come noto, si parla di “escatologia realizzata”, che trova un elemento proprio nella connessione tra credere nel Figlio e non andare perduti, non essere giudicati (come viene affermato subito dopo).
Alla fine del brano liturgico vengono riassunti gli stessi temi, insistendo di più sugli aspetti negativi (cf le negazioni); l’interessamento divino per l’umanità viene ribadito con la ripetizione tre volte in un solo versetto del termine “mondo”. Se prima si restava più a livello dell’intenzionalità di Dio, ora si passa alla realizzazione storica attraverso il Figlio mandato da lui sulla terra.