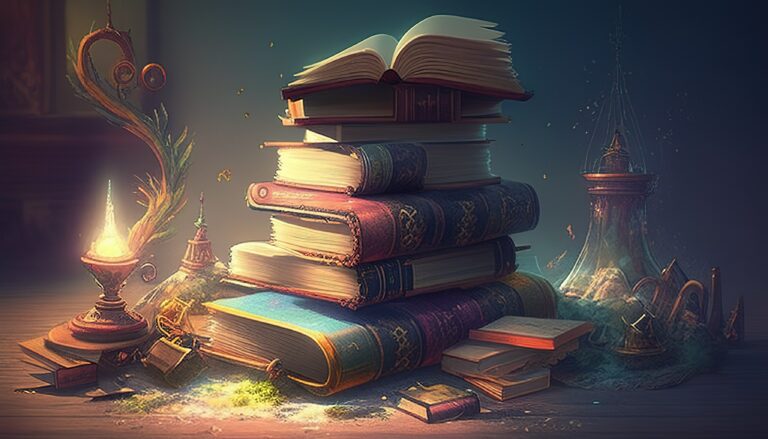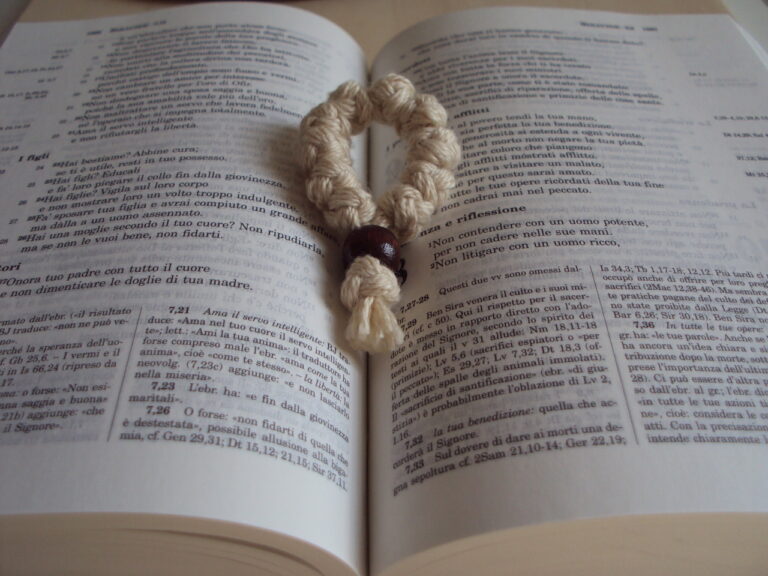Presentazione del Vangelo della Domenica
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 31 agosto 2025
Lc 14,1.7-1
Il brano, inizio di un’unità letteraria chiamata “detti conviviali” (14,1-24), perché ambientata all’interno di un banchetto (“convivio”, in forma più ricercata, dal latino “convivium”), continua il tono polemico con cui si concludeva il cap. 13; Gesù è ospite del banchetto escatologico di Dio (cf v.24), cui sono invitati tutti, eletti e non eletti. Il passo è delimitato dalla consueta espressione d’apertura “E avvenne” (di diretta derivazione dall’AT) e alla fine da una sentenza conclusiva della parabola di quelli che rifiutano l’invito di chi è detto “signore”, mentre, dopo, l’argomento cambia radicalmente, cessando il discorso sul cibo e la pericope comincia con un verbo seguito dalla particella “dé/poi” (viene usata molto spesso anche all’interno di una frase, ma senza valenza strutturale, per indicare una tappa nel ragionamento, come qui nel v.12).
Si precisano le circostanze di luogo e di tempo: “E avvenne nel recarsi lui a casa di uno dei capi dei farisei di sabato per mangiare pane” (semitismo per indicare un pasto). Più volte il vangelo richiama il fatto che lui va a mangiare in casa di qualcuno: (cf qui o nel contesto immediato), “… invitato a nozze…” (v.8; cf vv.7.9.10.12.13), “… quando offri un pranzo o una cena…” (v.12), “… quando offri un banchetto…” (v.13), “… una grande cena…” (v.15; cf vv.17.24). In particolare Lc nota che Gesù accetta spesso l’invito a mangiare con i Farisei (cf 7,36; 11,37; 14,1), dimostrando di essere interessato pure ad essi e alla loro salvezza. Del resto il terzo vangelo (forse più vicino alla realtà) mostra da parte di questi anche atteggiamenti favorevoli verso il rabbino di Nazareth. Nell’unità evangelica in esame si possono distinguere quattro elementi: il racconto di una guarigione (vv.1-6), due detti sui pasti (vv.7-11 e 12-14), la parabola della cena (vv.15-24). Il brano liturgico, dopo l’introduzione, presenta i due detti.
Essendo di sabato, doveva trattarsi di un pasto festivo; da testi giudaici si sa che, mentre nei giorni feriali si avevano due pasti, una modesta “colazione” nella mattinata e la “cena” alla fine del pomeriggio, il sabato, in segno di festa, si dovevano avere tre pasti, con quello più importante a mezzogiorno dopo la liturgia sinagogale; ad esso sovente si invitavano com-mensali. Il vangelo nel caso sottolinea che l’atteggiamento di questi verso Gesù era ostile: “ed essi erano osservanti lui”; non era “libero”, veniva badato. Probabilmente il particolare vuole far capire che l’invito del fariseo non era del tutto sincero, non era nato dal desiderio di avere un ospite noto, ma lo voleva controllare, spiare; Gesù accetta in ogni caso e coglie l’occasione per mostrare la sua potenza divina con la guarigione miracolosa dell’idropico, che lo porta a puntualizzare il valore del sabato, superando tutte le sottili disquisizioni farisaiche (cf vv.2-6, la parte tralasciata dalla liturgia), poi propone il suo insegnamento.
Il primo detto sui pasti è una sentenza di valore sapienziale; nel vangelo viene qualificato come “parabola”, ma da intendere in senso lato sul tipo dell’ebraico “māšāl” (si ricordi che il plurale di quel termine viene usato per intitolare il libro che in italiano è detto “dei Proverbi”, che è una raccolta di testi di vario tipo), che ha una costellazione di significati ad indicare “proverbio, sentenza, strofetta, parabola, massima, …”. Si parte dall’osservazione pratica della corsa ai primi posti (cf l’accusa ai Farisei in 11,43; 20,46; …), segno di arrivismo egoistico, e si dà una norma comportamentale di buon senso e di prudenza, che si trova già sia nella Bibbia (cf Pr 25,6-7) che nel Giudaismo e nella letteratura profana: uno avrà vergogna od onore, a seconda che sia fatto retrocedere od avanzare. Nella prima evenienza: “…comincerai con vergogna ad occupare l’ultimo posto”: perché i posti intermedi possono essere già occupati. Si ribadisce che dal caso concreto si risale ad un principio di ordine generale: “… ognuno esaltante sé sarà umiliato, ed umiliante sé sarà esaltato” (l’espressione ripete Ez 21,31, sia pure usata in altro contesto; ritorna in Lc 18,14 e richiama 16,15 dello stesso vangelo). Probabilmente nella formulazione passiva si nasconde un riferimento velato a Dio (secondo la nota usanza giudaica di evitare di coinvolgerlo direttamente); allora la sentenza potrebbe essere di origine semitica. Comunque, la promessa di rovesciamento delle situazioni si realizza pienamente con la venuta del regno di Dio, definitivo alla fine dei tempi, quindi anche qui si può vedere un rimando a questa, come sarà esplicitato più avanti, allorché si parla di “risurrezione dei giusti”. Così la regola conviviale della scelta dei posti a tavola diventa l’occasione per indicare l’atteggiamento di ammissione al Regno. Il riconoscere la propria pochezza richiama l’attenzione divina (cf 1,48.52).
Il secondo detto conviviale, introdotto “Disse poi”, non considera più l’invitato, ma colui che invita. Non bisogna preoccuparsi del “contraccambio”, ma rivolgersi a “poveri, storpi, zoppi, ciechi” che non sono in grado di ricambiare. Si tratta di un comportamento obbligatorio, poiché espresso con un imperativo che indica un comando, un qualcosa di sempre valido. Le categorie indicate erano quelle degli esclusi dalle cerimonie del tempio, persone considerate maledette da Dio (cf II Sm 5,8, soprattutto nella versione dei “Settanta”; Lv 21,18); proprio a questi è rivolta l’attenzione di Gesù, come deve essere per i suoi seguaci (cf Lc 14,21), sull’esempio del Padre celeste che si prende cura di tutti (cf Mt 5,45). Il pasto diventa, così, l’occasione per esprimere la generosità, l’amore disinteressato: non ci si rivolge a quelli con cui c’è qualche legame umano e che possono compensare l’invito con un altro invito, in modo che anche dietro un’azione apparentemente liberale si nasconda una forma di egoismo, non si deve seguire la logica comune del do ut des, ma considerare tutti, proprio dando, senza sperare nulla in contraccambio (cf Lc 6,35; At 20,35). Un simile comportamento è oggetto di beatitudine, perché il “contraccambio” che non possono dare gli indigenti sarà dato da Dio stesso: il vangelo è assolutamente chiaro in quanto usa il medesimo verbo nei due casi (non nella traduzione); ancora, come si notava, la forma passiva può nascondere il riferimento a Dio. Si richiama esplicitamente la vita eterna (nell’aspetto positivo), che deve essere il criterio ultimo di ogni comportamento.